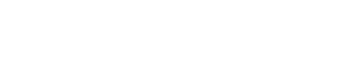Leggere la realtà:scrutando l'ambiente per capire e vivere meglio
Per riflettere insieme. Per intraprendere un’indagine attraverso un dialogo privo di confini prefissati e di tabù. Per avere uno scambio riflessivo e chiarificante sulle convinzioni personali e culturali, sui valori e gli atteggiamenti attraverso i quali ci mettiamo in relazione con il mondo. Un’idea, che prende le mosse da convincimenti propri, che tende a ripensare il senso della politica, recuperare l’accezione originale ed il coordinamento complessivo delle regole attinenti. A tal fine si suggerisce, una rilettura di alcuni concetti di filosofia classica e si propongono alcuni cenni di filosofia applicata alla pratica. Con l’impostazione, la disposizione e l’ipotesi di un progetto: si vuole esprimere un concetto che verte a conseguire, con la discussione, contributi e riflessioni integrativi, per stimolare un'innovazione pratica e concreta nel modo di comprendere, vivere, rendere produttiva e sviluppare la realtà operativa.
Gli uomini hanno bisogno della cultura e dell'organizzazione politica perché sono creature prive di doti naturali, per garantire loro: incolumità e benessere. Tutti si deve partecipare a queste due virtù "politiche". Esse non vanno viste come connaturate all'uomo, bensì come qualcosa di sopravvenuto, qualcosa che è trasmesso in maniera consapevole.
In origine, si racconta: “esistevano solo gli dei. Poi gli esseri viventi vengono fatti nascere dalla terra, e occorre distribuire loro le facoltà naturali che ne assicurino la sopravvivenza. Purtroppo, la distribuzione viene fatta dall'imprevidente Epimeteo, il quale, come dice il suo nome, è dotato solo del senno del poi: egli, infatti, quando giunge agli uomini, si rende conto di aver già distribuito tutte le doti naturali - denti, artigli, vista acuta, velocità nella corsa e così via - agli animali. Gli uomini, così, sono lasciati indifesi e naturalmente indeterminati. Il fratello di Epimeteo, Prometeo cerca di soccorrere gli uomini donando loro il fuoco e il sapere tecnico. Gli uomini, così, sviluppano linguaggio, cultura e religione: doti, quindi, non "naturali" ma "culturali". Ma vivono ancora isolati, perché sono privi dell'arte politica, e dunque della capacità di mediare e di coordinare le esigenze individuali. Deve intervenire Zeus in persona, per dare a tutti gli uomini aidos e dike, cioè pudore (come capacità di vergognarsi) e giustizia”.
Mentre Epimeteo distribuisce cose già pronte per l'uso, e utilizzabili solo in un modo, Prometeo - il dio dell’arte - dona all'uomo consapevolezza e possibilità di uno sviluppo autonomo. Le cognizioni tecniche possono essere distribuite secondo i criteri della divisione del lavoro; ma pudore e giustizia fanno dell'uomo un essere politico, cioè una creatura capace di vivere in uno spazio convenzionale e comune, e dunque devono essere assegnati a tutti. Evidentemente qui è il “sofista” che usa la retorica intesa come “ars retorica”: arte del dire bene che produce discorsi persuasivi nel rispettivo ambito di competenza e che hanno ad oggetto il giusto e l'ingiusto. Protagora illustra la convenzionalità dello spazio politico con un mito, della cui artificialità é consapevole: in seguito, infatti, egli cerca di argomentare, utilizzando la tesi del carattere culturale della politica con un ragionamento, che significativamente si fonda sulla funzionalità delle virtù "politiche". Fra Protagora il sofista e Solone il moralista non c'è grande differenza: la giustizia politica è una tecnica artificiale di mediazione che, però deve essere pensata come qualcosa di più - universale, comune, di origine “eccelsa”.
Come nota G. Cambiano (Platone e le tecniche, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 3-13) “Il mito narrato da Protagora rappresenta la società come un immenso apparato educativo: l'uomo si identifica con l'animale sociale, ed è tale solo perché possiede la "tecnica" politica. E in un ambiente in cui una determinata tecnica sia al centro dell'interesse sociale, tutti ne divengono almeno discreti possessori. Il sofista non insegna la tecnica politica, ma la perfeziona e fa progredire gli altri nella conoscenza - integrando dunque l'educazione tradizionale con una tecnica sofistica. Questo giustifica sia la struttura democratica ateniese, sia il compito del sofista: ma una simile giustificazione funziona solo nella misura in cui i valori della società sono compatti e non conflittuali. Soltanto con questo presupposto, infatti, è possibile pensare la tecnica politica come distribuita in tutti. Se questo presupposto viene meno, il rapporto fra tecnica e politica deve fare i conti con i problemi "prometeici[1]": come organizzare politicamente un sapere che fin dalla sua origine non è distribuito in modo uniforme?”
Nota, ancora, G. Cambiano: “Nella cultura greca arcaica le tecniche non erano un prodotto storico, soggetto ad essere inventato, ma una prerogativa di divinità. Ma l'accrescersi della divisione del lavoro mostrò che la tecnica è un insieme storico di procedure che si acquisiscono e si rinnovano nel tempo. Se concepire la divinità come portatrice di tecniche significa antropomorfizzarla[2], allora la critica all'antropomorfismo teologico conduce a dare agli uomini ciò che è degli uomini. Ma la visione tecnica del mondo presuppone una realtà imperfetta e mutevole… le technai sono il modello del sapere: la loro forza e la loro debolezza si fonda sulla delimitazione di un campo di competenza, connesso al loro oggetto. Questa delimitazione garantisce loro la possibilità di costruire, entro i propri ambiti, criteri univoci di correttezza, ma pone il problema del senso e del coordinamento complessivo delle tecniche. … Le tecniche si muovono in un mondo di conflitti possibili, cioè in un mondo che non è mai né tanto disordinato da non essere riconducibile a un ordine, né tanto ordinato da non poter diventare disordinato… Non siamo mai né nel sapere assoluto, né nella ignoranza assoluta: il nostro sapere è sempre un ricordare - un chiarire per se stessi e per gli altri - nel quale trasmissione, ricerca e apprendimento sono reciprocamente congiunti in un processo senza fine… il problema del sapere è inestricabilmente legato, in Platone, al problema della comunicazione del sapere”.
Una nuova forma di partecipazione
Abbassare il livello della tensione e dell’aggressività nelle organizzazioni attraverso il dialogo, la riflessione, l'approccio filosofico, può contribuire in modo sostanziale ad accrescere la dimensione etica nelle pratiche di tutti i giorni. Etica intesa come possibilità di contribuire con energie vitali per auto-affermarsi positivamente come individuo. Il che porta a prefigurare una nuova forma di partecipazione che parte dalla "pausa", dalla riflessione e solo in seguito si traduce in azione.
La filosofia applicata alla pratica della vita e del lavoro può aiutare a sospendere il giudizio, ad espandere e approfondire la capacità di comprendere la realtà, può farci ripensare e rivedere quelle che sono le nostre idee "originarie", alimentare la consapevolezza ed evocare nuove responsabilità in quello che facciamo.
Un’organizzazione sorretta da riscontri concreti, non può prescindere da una Visione del mondo: in cui si accetta che c'è qualcosa nell'ambiente che merita capire per vivere meglio. Al tempo stesso occorre riconoscere che esistono ambiti in cui la persona è richiamata allo scopo di ciò che fa e conosce. Tutto ciò può essere fondamento per comprendere, adattarsi all'ambiente e conferirgli senso: vale a dire “donare valore alla propria vita”. Abbiamo tutti bisogno di prendere le distanze dalle pressioni quotidiane che ci derivano dagli obiettivi da raggiungere a ogni costo: un "free space", uno "spazio libero", in questo senso, e' uno spazio per "riflettere prima di agire", un luogo per distanziarci temporaneamente dalle pressioni strategiche e operative.
Un’ipotesi di Progetto
Il progetto nasce dalla volontà di stimolare un'innovazione pratica e concreta nel modo di comprendere, vivere, rendere produttiva e sviluppare la realtà operativa. Fare questo collegando il sapere al fare nella consapevolezza che i due aspetti sono indissolubilmente legati nella realtà quotidiana attuale e futura.Fare questo in modo da dare voce a persone che vivono la società dall'interno o dall'esterno. Ciò nella consapevolezza che il successo della realtà attuale e futura dipende sempre più da un dialogo fresco e costruttivo basato sulla concretezza e praticità di pensiero e azione. Fare questo nella consapevolezza che il sapere alimenta il fare e a sua volta il fare alimenta il sapere generando un ciclo volto a far evolvere positivamente il legame fra l'espressione umanistica del potenziale individuale e di gruppo ed il raggiungimento degli obiettivi di produttività e redditività.Tutto ciò viene messo a fuoco allo scopo di stimolare un'evoluzione basata su una costruttiva analisi dell'esperienza vissuta e delle esperienze che si intendono vivere.
Il progetto nasce caratterizzato da tre sezioni: Valutazioni; Idee; Pratiche.
Le valutazioni riguardano idee e riflessioni inerenti a dei contenuti relativi ad argomenti isolati e scelti di comune accordo. L'obiettivo centrale delle valutazioni non è quello della critica fine a se stessa; l'obiettivo è quello di evidenziare osservazioni, idee, riflessioni e attività che possono dare un contributo attivo e positivo all'innovare pratico e concreto alla base del Perché progettuale sopra descritto.
Le idee riguardano osservazioni e riflessioni presentate con chiarezza, sotto qualsiasi forma. Sono inclusi in questo ambito anche teorie o modelli teorici purché abbinino alla sostanza delle idee: rapporto diretto con il mondo reale. Il concetto guida è quello di giungere a rendere semplici e comprensibili anche le teorie e riflessioni più complesse; in altre parole attingere dalla ricerca e dagli studi più aggiornati allo scopo di tradurli in concetti e strumenti utilizzabili.
Le pratiche riguardano testimonianze, in prima persona o nella forma di intervista, di vita quotidiana mettendo in particolare rilievo metodi, sistemi, azioni vissute come innovazioni e/o evoluzioni positive. In tal senso lo scopo è anche quello di favorire uno scambio di pratiche. Questo nella consapevolezza che la maggior parte delle innovazioni non nascono dal niente, ma spesso vengono adottate (e adattate) da contesti e campi di azione diversi rispetto al proprio.
Teoria economica e arte del governo
L’economia politica non è una scienza come le altre, che si possono valutare sulla sola base del principio di non contraddizione o ritagliare con il rasoio di Occam[3]; essa è invece una miscela di teoria economica e di arte del governo. Lo statuto della teoria economica, d’altra parte, non è quello delle scienze della natura e tanto meno quello della fisica newtoniana. Si deve dunque ammettere che non esiste la teoria economica, e il vero liberale dovrebbe concedere che esistono teorie economiche alternative. In altre parole, si dovrebbe riconoscere esplicitamente che la dimensione filosofica e politica del discorso economico non è estranea al corretto ragionamento economico, ma che di questo è costitutiva. L’ordine sociale in cui viviamo certamente produce ricchezza. E’, però un ordine tale, scrive Adam Smith, che “Con lo sviluppo della divisione del lavoro, l’occupazione della stragrande maggioranza di coloro che vivono di lavoro, cioè della gran massa del popolo, risulta limitata a poche semplicissime operazioni, spesso una o due. Ma ciò che forma l’intelligenza della maggioranza degli uomini è necessariamente la loro occupazione ordinaria. Un uomo che spenda tutta la sua vita compiendo poche semplici operazioni non ha nessuna occasione di applicare la sua intelligenza o di esercitare la sua inventiva a scoprire nuovi espedienti per superare difficoltà che non incontra mai. (...) In ogni società progredita e incivilita, questa è la condizione in cui i poveri che lavorano, cioè la gran massa della popolazione, devono necessariamente cadere a meno che il governo non si prenda cura di impedirlo”. Il lato negativo dell’ordine presente è la contraddizione tra la disoccupazione di massa e la massa dei bisogni sociali insoddisfatti, una contraddizione che l’ideologia del mercato tende a nascondere e che difficilmente il mercato riuscirà a comporre, essendone più probabilmente la causa. La questione del rapporto tra Stato e mercato torna dunque di grande attualità.
Per finire una Provocazione
Tutte le epoche sono state segnate dalla presenza di grandi leader. Persone straordinarie, dal carisma irresistibile, capaci di risvegliare sogni sopiti e di guidare le moltitudini verso il raggiungimento di nuovi scenari, che i più non riuscivano nemmeno ad immaginare. Leader era sinonimo di persona dalle grandi virtù, in grado di capire i bisogni e le speranze di un popolo. Era un essere che si distingueva per integrità morale e per forza interiore. Aveva un grande obiettivo da raggiungere e una determinazione inarrestabile nel perseguirlo. Così come vi sono state epoche segnate dalla presenza di grandi mistificatori[4]. Leader in negativo, che hanno strumentalizzato la loro influenza per il raggiungimento di interessi privati, e non del benessere comune. Non è necessario essere docenti di storia per poter affermare che, in ogni periodo storico, dopo l’avvento di uno o più leader negativi, si assiste a una giustificata riluttanza alla leadership. Un periodo durante il quale sembra che nessuno sia veramente disposto (o all’altezza) di caricare su di sé la responsabilità di guidare gli altri.
Ebbene, che ci piaccia o no, noi viviamo proprio in una di queste epoche. Nel secolo appena trascorso i grandi dittatori hanno creato fanatismo e, durante le ultime due guerre mondiali, in molti si sono immolati per dedizione nei loro confronti.
Gli ultimi eventi terroristici ci hanno dimostrato, ancora una volta, gli effetti nefasti prodotti da persone abilissime a fomentare pericolosi integralismi religiosi, pur di rafforzare il proprio potere. Ma è evidente come queste ultime non siano reali manifestazioni di leadership. Ovunque si guardi, è difficile trovare persone di reale spessore carismatico, e la gente avverte una totale mancanza sia di ideali che di reale interesse, da parte di chi, in teoria, li dovrebbe governare. Con la triste conseguenza che ormai si finisce, in mancanza d’altro, con il mitizzare il proprio attore o cantante preferito. Tutti noi avvertiamo questo vuoto che nemmeno le religioni, nuove o tradizionali, riescono più a colmare, poiché lontane dai bisogni, sempre più complessi, di un’umanità che si evolve senza un vero obiettivo o scopo comune. Ci troviamo, quindi, in un periodo storico estremamente delicato, in cui questo trono vacante non trova un vero sovrano che voglia (o possa) prendersi la responsabilità di migliorare, concretamente, l’esistenza umana. Eppure, a voler guardare il mondo attuale in maniera pragmatica, scorgiamo chi potrebbe ricoprire il vero, e ormai dimenticato, ruolo di leader.
Queste persone sono i nuovi condottieri dell’epoca moderna, sono i soli che possiedono il potere di cambiare la qualità della vita di milioni di uomini a seconda delle proprie scelte ed azioni. Queste persone sono gli imprenditori di tutto il mondo. Sappiamo che un’affermazione del genere potrà apparire forte, o provocatoria. Eppure, ad una riflessione attenta, apparirà evidente ed elementare quanto ogni singolo titolare d’azienda possa fare per ciascun essere umano, che vive gran parte della propria giornata in un ambiente lavorativo.
Ormai l’azienda è diventata il luogo in cui si amplificano le sempre più evidenti lacune della scuola, della famiglia e della società in genere. Ma anche l’unico luogo in cui queste lacune possono e dovrebbero essere colmate. Decidere di assumersi questa responsabilità, diventando un vero leader nei confronti del proprio personale e della società intera, potrebbe davvero rappresentare una trasformazione epocale, priva di ideologie politiche o religiose. Significherebbe dare sfogo ad una naturale esigenza umana: da sempre avere un leader tranquillizza e rafforza un gruppo, permettendo l’evoluzione della specie. Creerebbe un cambiamento radicale nella vita quotidiana di tutti noi, disillusi ormai da falsi leader, tanto potenti quanto lontani dai reali bisogni della gente. Potrebbe essere un ritorno al leader nel suo significato più vero, capace di produrre miglioramenti concreti nella vita della gente. Un aiuto vero a tutti coloro che dedicano la propria vita alla famiglia e al lavoro, e che in cambio ottengono solo frustrazioni e insoddisfazioni. Un leader puro, che porti positività, che sappia far trionfare le persone che lo circondano, e che dia uno scopo grande e condivisibile a tutti coloro che amano crescere nell’arco della propria vita. Un nuovo condottiero, destinato a ribaltare lo stereotipo dell’imprenditore: non solo creatore di ricchezza materiale, ma anche – e soprattutto – di ricchezza interiore.
· E se sembrerà che io mi sono troppo attenuto alle parole degli autori, l'ho fatto per evitare di portare i lettori lontano dalla verità…
(Fra Tommaso Fazello)
· "Gli autori originali dei tempi moderni non sono tali perché abbiano prodotto qualcosa di nuovo, ma perché sono capaci di dire le stesse cose come se non fossero mai state dette prima” (JOHANN W. GOETHE)
Bibliografia[5]
[1] Prometeico è sinonimo di titanico e contiene in se l'idea di sfida contro il potente, l'autorità, l'imposizione, una sfida che può anche essere votata al fallimento, ma che viene affrontata con fiera determinazione: una lotta prometeica contro il destino. Prometeico è l'aggettivo di Prometeo, un Titano della mitologia greca, il quale con il fango formò il primo uomo e per lui rubò il fuoco a Zeus.
[2] Antropomorfismo: la tendenza a rappresentarsi la natura e l’operare della divinità in analogia con la natura e l’operare degli uomini.
[3] È il rasoio di Occam, dal nome del filosofo inglese Guglielmo di Occam, vissuto tra il 1285 e il 1347. Tra due teorie entrambe capaci di spiegare un gruppo di dati occorre scegliere quella più semplice e dotata di un minor numero di ipotesi, “tagliando via” con il rasoio di Occam quella più lunga e involuta. Non tanto perché una sia più “vera” dell’altra, quanto perché quella più breve e compatta permette di risparmiare tempo e fatica inutili.
[4] Mistificatori: Ingannatori, persone che fanno apparire qualcosa in modo diverso dalla realtà.
[5] Il Protagora di Platone –
G. Cambiano (Platone e le tecniche, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 3-13 –
Francesco Barone Il filosofo e il falegname
Leadership riflessive di Andrea Vitullo -
Professione Lavoro
Dal Liberalismo al Liberismo di Daniele Besomi e Giorgio Rampa -
I Nuovi Condottieri di Paolo A. Ruggeri –